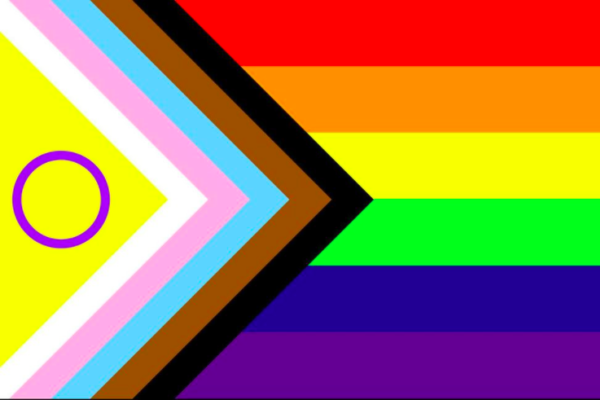Detesto dirlo ma dò ragione a chi (Calenda, sob…e davvero destesto dirlo) sostiene che si debba definire un’identità e quella definizione non può contemplare Bonelli/Fratoianni con Calenda ma anche tantissima parte del PD che non ha seguito Renzi ma che da quella storia, da quella visione di Paese viene. Dire no ai rigassifigatori non ha nulla di ambientalista (tanto per capirci sul termovalorizzatore ho un’idea diversa da Calenda, servono impianti di trattamento nel 2022, non siamo nel 1990).
Il PD ha la palla in mano dell’identità di quello schieramento che NON può essere solo NO Meloni, No Salvini anche se ho una lista lunga un KM per dire di NO a Meloni e a Salvini. Ma per parlare alla maggioranza del Paese serve delineare un piano, una visione e quella roba lì non passa per degli slogan. Il Lavoro! Che vuol dire il lavoro? Per me (per esempio, eh): diminuzione costo del lavoro, incentivi per chi ha codici ATECO ad alto peso di Mano d’Opera, RDC a tempo con vero reintegro, ma salario minimo.
Sedetevi: delineate un programma sulle cose più importanti, sul posizionamento internazionale (oggi più che mai fondamentale, importante, vitale, necessario, CONDITIO SINE QUA NON) e poi diteci se state insieme per 5 anni su queste cose o se dovete fare un accrocco per farvi votare contro Meloni. In questo ultimo sciagurato caso, ci sta che io vi voterò (dando sopravvivenza ad una quasi eterna classe dirigente) ma un bel pezzo di Paese che è quello che CI serve per poter avere una possibilità di futuro dica: ANCHE NO. Quindi, che si fa?